Le avventure del califfo Harun-al-Rashid
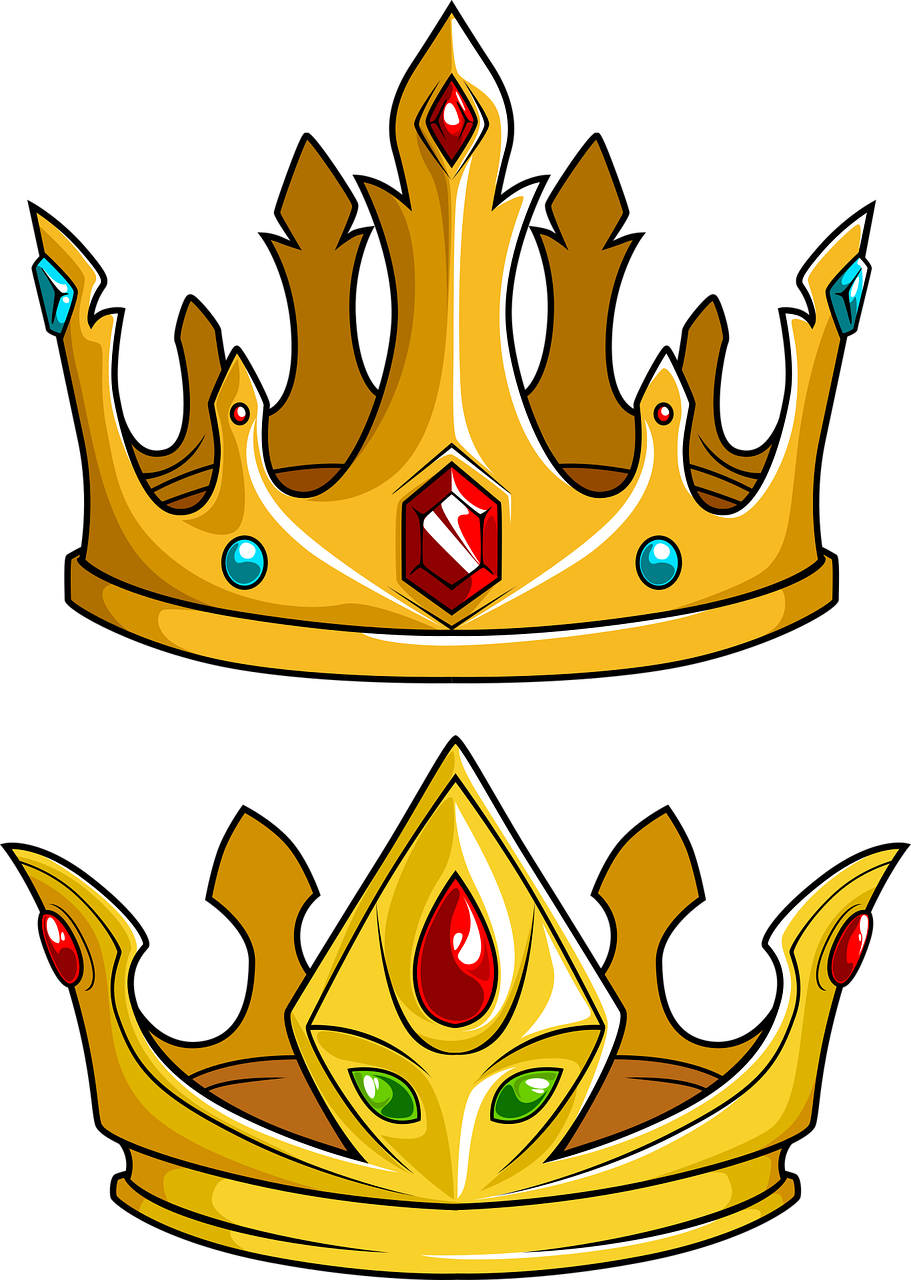
Sire, ho raccontato parecchie volte alla Maestà Vostra qualche avventura capitata al celebre califfo Harun-al-Rashid; gliene sono capitate tante altre, tra queste quella che ora racconterò non è meno degna della vostra curiosità. A volte, Maestà, come non ignorate e come forse avete voi stesso provato, ci troviamo in preda a slanci di gioia così straordinari, che subito comunichiamo questa passione a quelli che ci avvicinano, o partecipiamo con facilità alla loro. Ma altre volte, siamo in preda aduna malinconia così profonda da diventare insopportabili a noi stessi e, ben lontani dal poterne indicare la ragione se ce la chiedessero, neanche noi potremmo trovarla se la cercassimo.
Un giorno il califfo si trovava in questo stato d’animo, quando Giafar,il suo fedele e amato gran visir, si presentò davanti a lui. Il ministro lo trovò solo, il che gli capitava molto raramente,e accorgendosi, mentre gli si avvicinava,che il califfo era di umore pessimo e non alzava neppure gli occhi su di lui, si fermò aspettando che egli si degnasse di guardarlo. Finalmente il califfo alzò gli occhi e guardò Giafar, ma subito li distolse, restando nello stesso atteggiamento, immobile come prima. Il gran visir,non vedendo negli occhi del califfo nessun segno di scontento che lo riguardasse personalmente, prese la parola: “Principe dei credenti” disse, “Vostra Maestà mi permetta di chiedere quale può essere la ragione della malinconia che vi traspare dal viso e alla quale mi siete sempre sembrato così poco propenso.” “È vero, visir” rispose il califfo cambiando espressione, sono un pò triste.. mi farai piacere inventando qualche cosa per scacciarla.” “Principe dei credenti” riprese il gran visir Giafar, “solo il mio dovere mi ha spinto a venire qui, e mi prendo la libertà di ricordare alla Maestà Vostra che vi siete imposto il dovere di informarvi personalmente del buon andamento della vigilanza che volete sia esercitata nella vostra capitale e nei dintorni. Oggi è il giorno che avete fissato per questo scopo ed è l’occasione più propizia che si offre spontaneamente per dissipare le nubi che offuscano la vostra solita allegria.” “L’avevo dimenticato” replicò il califfo, “e tu me ne fai ricordare molto a proposito: vai dunque a cambiarti d’abito mentre a mia volta farò la stessa cosa.”
Ognuno di loro indossò un abito da mercante straniero e, così travestiti, uscirono soli per una porta segreta del giardino del palazzo, che dava sulla campagna. Fecero una parte del giro della città all’esterno, fino alla riva dell’Eufrate, a una distanza considerevole dalla porta della città che era da quella parte, senza osservare niente che fosse contrario al buon ordine. Attraversarono il fiume sul primo battello che capitò; e, dopo aver terminato il giro dell’altra parte della città, opposta a quella che avevano lasciato, si diressero nuovamente verso il ponte che collegava le due parti. Attraversarono il ponte, in fondo al quale incontrarono un cieco piuttosto anziano che chiedeva l’elemosina. Il califfo si girò verso di lui e gli mise in mano una moneta d’oro. Subito il cieco gli afferrò la mano e lo trattenne. “Persona caritatevole,” disse, “chiunque siate voi al quale Dio ha ispirato di farmi l’elemosina, non negatemi la grazia che vi chiedo di darmi uno schiaffo: l’ho meritato, e anche un castigo più severo.” Dette queste parole, lasciò la mano del califfo affinché avesse la possibilità di dargli lo schiaffo; ma, temendo che passasse oltre senza farlo, lo trattenne per il vestito. Il califfo, stupito dalla domanda e dal gesto del cieco, disse: “Buon uomo, non posso accordarti quello che mi chiedi: mi guarderò bene dal cancellare il merito della mia elemosina maltrattandoti come tu vuoi che faccia.” E, dette queste parole, fece uno sforzo per far lasciare la presa al cieco. Il cieco, che aveva immaginato l’opposizione del suo benefattore, per l’esperienza che ne aveva da tanto tempo, fece uno sforzo maggiore per trattenerlo. “Signore,” ricominciò a dire, “perdonate il mio ardire e la mia importunità e datemi, vi prego, datemi uno schiaffo, o riprendetevi l’elemosina; posso accettarla solo a questa condizione, altrimenti verrei meno a un solenne giuramento che ho fatto davanti a Dio; e, se ne conoscete il motivo, sareste d’accordo con me che la pena è molto lieve.”
Il califfo, che non voleva essere trattenuto oltre, cedette all’insistenza del cieco e gli diede uno schiaffo piuttosto leggero. Immediatamente il cieco lasciò la presa ringraziandolo e benedicendolo. Il califfo si rimise in cammino con il gran visir, ma, dopo qualche passo, disse a Giafar: “Quel cieco deve avere un motivo molto grave per comportarsi così con tutti quelli che gli fanno l’elemosina. Mi farebbe piacere conoscerlo: quindi,torna indietro; rivelagli chi sono, e digli di non mancare di venire domani a palazzo, all’ora della preghiera del pomeriggio, perché voglio parlargli.” Il gran visir tornò sui suoi passi, fece l’elemosina al cieco; e, dopo datogli uno schiaffo, gli diede l’ordine e tornò a raggiungere il califfo.
Rientrarono in città; e passando per una piazza, videro un gran numero di spettatori che guardavano un uomo giovane ed elegante, in sella a una cavalla che spronava una briglia sciolta intorno alla piazza, maltrattandola crudelmente a colpi di frusta e di speroni, senza darle tregua, in modo che la bestia schiumava ed era tutta insanguinata. Il califfo, stupito della crudeltà del giovane, si fermò per chiedere se sapessero per quale ragione egli maltrattasse così la sua cavalla; gli risposero che lo ignoravano, ma che già da parecchio tempo, ogni giorno alla stessa ora, egli le faceva fare questo penoso esercizio. Essi proseguirono oltre, e il califfo disse al gran visir di osservare bene quella piazza e di non mancare di convocare da lui quel giovane, il giorno dopo, alla stessa ora del cieco. Prima che il califfo arrivasse a palazzo, notò in una strada, per la quale non passava da molto tempo, un edificio costruito di recente, che gli parve il palazzo di qualche signore di corte. Chiese al gran visir se sapeva a chi appartenesse. Il gran visiri rispose d’ignorarlo, ma che andava ad informarsene. Infatti interrogò un vicino, il quale gli disse che la casa apparteneva a Cogia Hassan, soprannominato Alhabbal. Il suo mestiere di cordaio che egli stesso gli aveva visto esercitare in grande povertà e che, senza che si sapesse in che modo la fortuna lo avesse favorito, aveva accumulato dei beni tanto grandi da poter sostenere molto onorevolmente la spesa che aveva affrontato per farla costruire. Il gran visir raggiunse il califfo e gli riferì ciò che aveva saputo. “Voglio vedere questo Cogia Hassan Alhabbal,” gli disse il califfo, “vai a dirgli di trovarsi domani al mio palazzo, alla stessa ora degli altri due.”
Il gran visir non mancò di eseguire gli ordini del califfo. Il giorno successivo, dopo la preghiera del pomeriggio, il califfo entrò nel suo appartamento e il gran visir vi introdusse subito i tre personaggi di cui abbiamo parlato e li presentò al califfo. Tutti e tre si prosternarono davanti al trono del sultano; e, quando si furono rialzati, il califfo chiese al cieco come si chiamasse. “Mi chiamo Babà-Abdallà” rispose il cieco. “Babà-Abdallà” riprese il califfo, “il tuo modo di chiedere l’elemosina mi sembrò ieri così strano che, se non fossi stato trattenuto da alcune considerazioni, mi sarei ben guardato dall’avere la compiacenza che ho avuto per te, ti avrei già da allora impedito di continuare a dare in pubblico questo scandalo. Ti ho dunque fatto venire qui per sapere da te quale è la ragione che ti ha spinto a fare un giuramento tanto irragionevole; e, da quello che mi dirai, giudicherò se hai fatto bene e se devo permetterti di continuare un’usanza che mi sembra di pessimo esempio. Dimmi, dunque, senza nascondermi niente, come ti è venuta questa stravagante idea: non nascondermi niente, perché voglio assolutamente saperlo.” Babà-Abdallà, intimidito da questo rimprovero, si prosternò una seconda volta con la fronte a terra, davanti al trono del califfo; e, dopo essersi rialzato, disse subito: “Principe dei credenti, Maestà, vi chiedo molto umilmente perdono dell’ardire con il quale ho osato esigere da voi, e forzarvi a fare una cosa che per la verità sembra priva di buon senso.Riconosco la mia colpa; ma, poichéin quel momento, Maestà non vi conoscevo, imploro la vostra clemenza. Spero che terrete conto della mia ignoranza. Quanto a quello che voi considerate una mia stravaganza, ammetto che lo è e la mia usanza deve sembrare tale agli occhi degli uomini; ma, di fronte a Dio è una penitenza molto blanda per un enorme peccato che ho commesso e che non riuscirei a espiare neppure se tutti i mortali mi caricassero di schiaffi gli uni dopo gli altri. Maestà,quando ascolterete la mia storia, che ora racconterò per ubbidire ai vostri ordini, e avrete saputo qual è quest’enorme colpa, ne sarete giudice voi stesso.
- Fiaberella

