Storia di Sinbad il marinaio-Parte VI
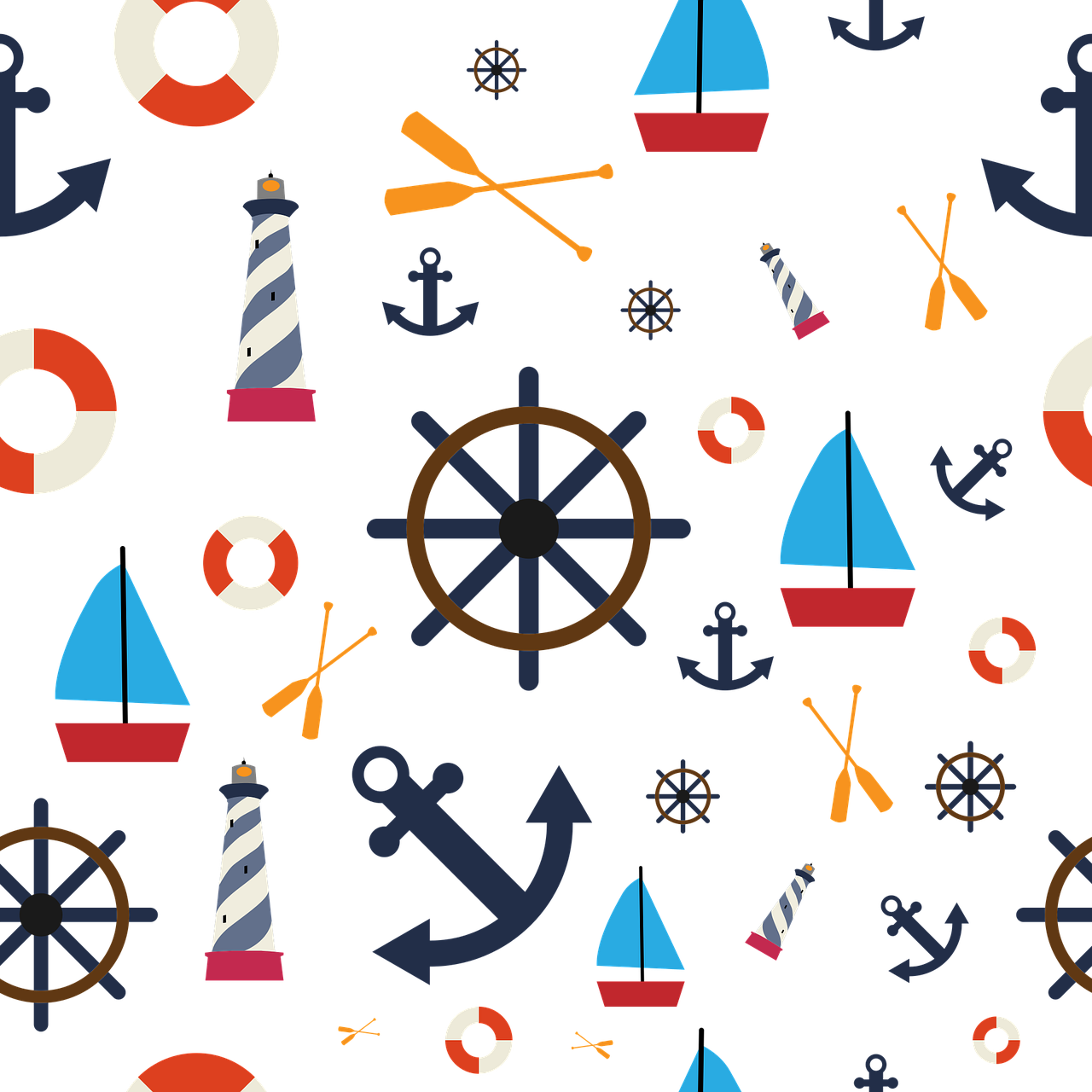
“Signori” disse loro “certamente voi siete ansiosi di sapere come, dopo aver fatto cinque naufragi e aver sostenuto tanti pericoli, io potessi risolvermi un’altra volta a tentare la sorte e a cercare nuove disgrazie. Io stesso ne sono meravigliato quando vi rifletto, e sicuramente bisogna che io fossi protetto dalla mia stella. Checché ne sia, dopo un anno di riposo, mi preparai a fare un sesto viaggio, malgrado le preghiere dei miei parenti e amici, che fecero quanto era in loro potere per trattenermi. Invece di prendere il cammino verso il Golfo Persico, passai di nuovo per varie province della Persia e delle Indie, e giunsi in un porto di mare dove mi imbarcai su un buon naviglio, il cui capitano era risoluto a fare una lunga navigazione. E invero fu lunghissima, ma al tempo stesso sventurata, perché il capitano ed il pilota persero la direzione fino a ignorare totalmente dove fossero. Quando finalmente riuscirono a orientarsi, non avemmo motivo di rallegrarcene, e restammo attoniti nel vedere il capitano abbandonare il suo posto gridando, gettare a terra il suo turbante, strappandosi la barba e battendosi la testa, come un uomo a cui la disperazione ha sconvolto la mente. Gli domandammo perché fosse così agitato. “Vi annuncio”, ci rispose, “che siamo nel punto più pericoloso del mare. Una rapidissima corrente trascina la nave, e fra un quarto d’ora saremo tutti morti. Pregate Iddio che ci liberi da simile pericolo; da soli non ci sarà possibile sfuggirvi, se Egli non ha pietà di noi.” Dopo tali parole ordinò di mettere in ordine le vele; ma le corde si ruppero nella manovra e la nave, senza che fosse possibile oppor-visi, fu trascinata dalla corrente ai piedi d’una montagna inaccessibile, contro cui andò a incagliarsi, dandoci però il tempo di salvare le nostre persone e di sbarcare i nostri viveri e le nostre merci. “Iddio ha disposto così. Qui possiamo scavare le nostre fosse e darci l’ultimo addio, perché nessuno di quelli che vi sono stati gettati prima di noi è ritornato a casa!”
Tale discorso ci immerse in una mortale afflizione e ci abbracciammo l’un l’altro, con le lacrime agli occhi, deplorando la sorte infelice. La montagna, ai cui piedi eravamo, formava le coste di un’isola molto lunga e vastissima. Quella costa era tutta coperta dei resti di navigli che vi avevan fatto naufragio e il grandissimo numero di ossa umane che si vedeva ovunque ci rivelò che moltissimi naufraghi erano morti in quel luogo, e ciò ci fece fremere d’orrore. Era quasi incredibile la quantità di mercanzie e di ricchezze che si presentavano ai nostri occhi da ogni lato. Ma tutti quegli oggetti servivano solo ad aumentare la desolazione in cui eravamo. Dappertutto altrove i fiumi escono dal loro letto per gettarsi in mare: ma là, al contrario, un grosso fiume d’acqua dolce s’allontana dal mare e penetra nella costa attraverso una grotta oscura, la cui apertura è estremamente larga e alta. Ciò che in quel luogo è più straordinario è che i sassi delle montagne sono di cristallo, di rubino e di altre pietre preziose. Vi si vede anche la sorgente di una specie di pece o di bitume che cola nel mare; i pesci l’inghiottono, rendendolo poi, tramutato in ambra grigia, che le onde rigettano sulla spiaggia che ne rimane coperta. Vi crescono anche degli alberi d’aloe, che non sono certo meno belli di quelli dell’isola di Comari. Per completare la descrizione di quel luogo, dirò che i navigli non possono allontanarsene una volta che si siano avvicinati. Infatti se essi sono stati spinti dal vento di mare, il vento e la corrente li fanno naufragare, e il vento di terra, che potrebbe aiutarli ad allontanarsi, non soffia mai perché l’altezza della montagna lo arresta e produce una calma, che lascia agire la corrente, che li trascina contro la costa dove si schiantano come era accaduto al nostro. Per colmo di sfortuna, non è possibile salire sulla vetta della montagna, né fuggire per via di terra. Restammo sulla riva, come gente uscita di senno, attendendo la morte di giorno in giorno. Fin dall’inizio avevamo diviso i nostri viveri in parti uguali, così si può dire che ciascuno visse più o meno quanto gli altri, secondo la sua resistenza naturale e secondo l’uso che fece delle sue provviste. Quelli che perirono per primi,” proseguì Sindibàd, “furono sotterrati dagli altri; in quanto a me, resi gli ultimi onori a tutti i miei compagni, e non bisogna meravigliarsi, perché, oltre al fatto che seppi usare parcamente le provviste che mi erano toccate in sorte, ne avevo anche delle altre di cui mi ero ben guardato dal far parte ai miei compagni. Pure, quando sotterrai l’ultimo compagno, mi restavano così pochi viveri, che ritenevo di non poter durare a lungo. Allora scavai da me stesso la mia tomba, risoluto a gettarmici da solo, giacché non c’era più nessuno per seppellirmi. Vi confesserò che nell’occuparmi di simile lavoro non potevo astenermi dal pensare che ero la causa della mia perdita, e mi pentivo di essermi impegnato in tale viaggio. Ma Iddio ebbe ancora pietà di me, ispirandomi di andare fino al fiume che si perdeva sotto la volta della grotta. Là, dopo averlo esaminato con molta attenzione, dissi fra me: ‘ Questo fiume, che qui si nasconde sotto terra, deve pur uscire da qualche parte. Costruirò una zattera, e vi salirò, abbandonandomi alla corrente dell’acqua. Giungerò a una terra abitata o morrò; se muoio, non avrò fatto che cambiare genere di morte, se, al contrario, esco da questo luogo fatale, non solamente eviterò il destino dei miei compagni, ma troverò forse una nuova occasione per arricchirmi. Chi sa che la fortuna non mi aspetti all’uscita di questo infame scoglio, per rifarmi ad usura dei danni del naufragio? ‘.
Dopo questo ragionamento mi misi a lavorare attorno alla zattera usando buoni pezzi di legno e grossi cavi, legandoli insieme così forte, da farne un piccolo vascello abbastanza solido. Quando fu terminato, lo caricai di alcune balle di rubini, di smeraldi, d’ambra grigia, di cristallo di rocca e di stoffe preziose. Avendo messo tutte queste cose in equilibrio e avendole solidamente legate, m’imbarcai sulla zattera con due piccoli remi che non avevo dimenticato di fare, e lasciandomi trascinare dal corso del fiume, mi abbandonai alla volontà di Dio. Appena fui sotto la volta, non vidi più luce, e la corrente mi trascinò senza che potessi vedere dove mi trasportava. Navigai per alcuni giorni in quell’oscurità, senza mai scorgere un raggio di luce. In un’occasione trovai la volta così bassa da esserne schiacciato^ il che mi rese molto attento a evitare un simile pericolo. Durante quel tempo razionavo i viveri che mi restavano, mangiando solo quanto era sufficiente per sostentarmi: ma benché vivessi con frugalità, finii per esaurire le mie provviste. Allora, senza che lo potessi impedire, un dolce sonno venne ad impadronirsi dei miei sensi. Non posso dirvi se dormii a lungo: ma quando mi svegliai mi trovai con meraviglia in una vasta campagna, in riva ad un fiume, dove la mia zattera era legata, in mezzo ad un gran numero di negri. Mi alzai, appena li ebbi scorti, e li salutai. Mi parlarono, ma io non capivo la loro lingua. Ero così felice che temevo si trattasse di un sogno. Persuasomi alla fine di essere desto, gridai e recitai questi versi arabi:
«Invoca l’Onnipotente, ed Egli verrà in tuo soccorso. Non c’è bisogno che tu t’incarichi d’altra cosa.
Chiudi gli occhi, e mentre dormirai Iddio cambierà la tua fortuna da male in bene».
Uno dei negri che capiva l’arabo, avendomi udito parlare in questo modo, si fece innanzi e prese la parola: “Fratello”, mi disse, “non siate meravigliato di vederci. Noi abitiamo questa campagna e siamo venuti oggi ad irrigare i nostri campi con l’acqua di questo fiume che esce dalla montagna vicina, deviandola con piccoli canali. Abbiamo osservato che l’acqua portava qualche cosa; siamo subito corsi a vedere cosa fosse mai, e abbiamo trovato che era questa zattera; allora uno di noi si è gettato a nuoto e l’ha portata qui. L’abbiamo legata come vedete e aspettavamo che vi svegliaste. Vi supplichiamo di raccontarci la vostra storia, che deve essere straordinaria. Diteci come mai vi siete trovato su questo fiume e da dove venite”. Risposi loro che mi dessero prima da mangiare e che avrei soddisfatto la loro curiosità. Mi offrirono molte sorte di vivande, e quando ebbi placata la fame, feci loro una relazione fedele di tutto ciò che mi era accaduto: essi mi ascoltarono con molta ammirazione. Appena ebbi finito il mio discorso, mi dissero, per bocca dell’interprete, che aveva tradotto loro ciò che io avevo detto: “Ecco una storia delle più meravigliose! Bisogna che voi stesso veniate ad informarne il re. La cosa è straordinaria e non può essergli riferita da altri se non da colui al quale è avvenuta”. Risposi loro che ero pronto. I negri mandarono subito a prendere un cavallo che fu condotto poco dopo; mi avviai cavalcando mentre una parte di loro camminava davanti a me mostrandomi la via, e gli altri, che erano i più robusti, mi seguivano, dopo essersi caricata la zattera, tal quale si trovava, col suo carico di balle. Camminammo tutti insieme” proseguì Sindibàd “fino alla città di Serendib, poiché in quell’isola appunto mi trovavo. I negri mi presentarono al loro re. Mi avvicinai al trono, su cui egli stava seduto, e lo salutai come si suole salutare i re delle Indie, vale a dirami prostrai ai suoi piedi e baciai la terra. Quel principe mi fece avvicinare e prendere posto vicino a sé. Mi domandò in primo luogo come mi chiamassi. Avendogli risposto che mi chiamavo Sindibàd, soprannominato il Marinaio, a causa dei viaggi che avevo fatto per mare, aggiunsi che ero cittadino della città di Bagdad. “Ma”, egli soggiunse, “come vi trovate nei miei stati, e per dove siete venuto?” Non nascosi nulla al re; gli feci lo stesso racconto che ho fatto ora a voi e ne fu così sorpreso e soddisfatto, che comandò si scrivesse la mia avventura a lettere d’oro, per essere conservata negli archivi del suo regno. Fu recata quindi la zattera, e si aprirono le balle in sua presenza. Egli ammirò la quantità di legno d’aloe e d’ambra grigia, ma soprattutto i rubini e gli smeraldi, perché non ne aveva nel suo tesoro di così grande Valore. Notando che egli guardava le mie pietre preziose con piacere e che ne esaminava le più singolari le une dopo le altre, mi prosternai e presi la libertà di dirgli: “Sire, non solo la mia persona è a servizio di vostra maestà, ma anche il carico della zattera vi appartiene, ed io vi supplico di disporne come di un bene di vostra proprietà”. Egli disse sorridendo: “Sindibàd, mi guarderei bene dall’averne il minimo desiderio e dal togliervi nulla di ciò che Dio v’ha dato. Anziché diminuire le vostre ricchezze, io voglio accrescerle e non permetterò che usciate dai miei stati senza portare con voi un segno della mia generosità”. Risposi a tali parole facendo voti per la prosperità del principe e lodando assai la sua bontà e generosità. Egli incaricò uno dei suoi ufficiali d’aver cura di me, e scelse delle persone per servirmi, a sue spese. Quell’ufficiale eseguì fedelmente gli ordini del suo padrone, e fece trasportare nell’alloggio in cui mi condusse, tutte le balle di cui la zattera era carica.
Io andavo ogni giorno a fare visita al re, ed impiegavo il resto del tempo a visitare la città. L’isola di Serendib è situata precisamente sotto la linea equatoriale, quindi i giorni e le notti vi sono sempre di dodici ore. La capitale è situata all’estremità di una bella valle, a ridosso di una montagna, la più alta che vi sia al mondo. Infatti là si scopre il mare alla distanza di giornate di navigazione. Vì si trovano il rubino e molte specie di minerali; il rimanente è formato di smeriglio, pietra metallica di cui sìia uso per tagliare le pietre preziose. Vi si vede ogni sorta di alberi e di piante rare, specialmente il cedro ed il cocco. Si pescano anche le perle lungo le sue coste e all’imboccatura dei fiumi, e alcune delle sue valli forniscono il diamante. Feci pure per devozione un viaggio alla montagna dove, secondo la nostra fede, fu relegato Adamo, dopo essere stato bandito dal Paradiso terrestre. Quando fui tornato in città, supplicai il re di permettermi di ritornarmene al mio paese: egli me lo accordò molto gentilmente, obbligandomi ad accettare un ricco dono, che fece trarre dal suo tesoro. Quando stavo per prendere commiato da lui, mi dette un altro dono ben più considerevole, insieme a una lettera che m’incaricò di consegnare al califfo nostro sovrano signore, dicendomi: “Vi prego di presentare da parte mia questo regalo e questa lettera al califfo Harùn ar-Rashìd e di assicurarlo della mia amicizia”. Io presi rispettosamente il dono e la lettera, promettendogli di eseguire puntualmente gli ordini di cui mi faceva l’onore d’incaricarmi. Prima d’imbarcarmi quel principe mandò a chiamare il capitano e i mercanti che dovevano fare il viaggio con me, e comandò loro di usarmi tutti i riguardi immaginabili.
La lettera del re di Serendib era scritta sulla pelle di un certo animale molto preziosa a cagione della sua rarità, e il cui colore tende al giallo. I caratteri di quella lettera erano di colore azzurro; ed ecco ciò che conteneva in lingua indiana:
«Il re delle Indie, innanzi a cui marciano mille elefanti, che dimora in un palazzo, il cui tetto brilla dello splendore di centomila rubini, e che possiede nel suo tesoro ventimila corone ornate di diamanti, al califfo Harùn ar-Rashìd. Benché il dono che vi mandiamo sia poco considerevole, nondimeno non mancate di accettarlo da fratello, in considerazione dell’amicizia che noi nutriamo per voi nel nostro cuore e di cui ci siamo compiaciuti di darvi una testimonianza. Vi domandiamo di contraccambiare il nostro sentimento, e crediamo di meritarlo, essendo di grado pari a quello da voi occupato. Ve ne scongiuriamo in qualità di fratello. Addio.»
Il dono consisteva in un vaso tagliato in un solo rubino, scavato e lavorato a uso di coppa, di mezzo piede di altezza e di un dito di spessore, pieno di perle rotondissime e tutte del peso di mezza dramma; una pelle di serpente che aveva delle scaglie grandi quanto una moneta ordinaria d’oro e la cui proprietà era di preservare dalle malattie coloro che vi si sdraiavano sopra; cinquantamila dramme di legno d’aloe eccellente, con trenta grani di canfora della grandezza di un pistacchio; il tutto era accompagnato da una schiava di una bellezza incantevole, le cui vesti erano coperte di pietre preziose. La nave si mise in viaggio, e dopo una lunga e felicissima navigazione approdammo a Bassora, da dove mi recai a Bagdad. La prima cosa che feci dopo il mio arrivo, fu di adempiere all’incarico che mi era stato affidato. Presi la lettera del re di Serendib, andai a presentarmi alla porta del califfo, seguito dalla bella schiava e dalle persone della mia famiglia, che portavano i doni di cui ero stato incaricato. Subito fui condotto davanti al trono del califfo. Lo salutai prosternandomi, e, dopo avergli fatto un discorso molto conciso, gli presentai la lettera e il dono. Quand’ebbe letto ciò che gli mandava a dire il re di Serendib, mi domandò se fosse vero che quel principe era tanto ricco e potente quanto diceva nella sua lettera. Mi prostrai per la seconda volta, e, dopo essermi rialzato, gli risposi: “Grande califfo, posso assicurare la vostra maestà che egli non esagera affatto le sue ricchezze e la sua grandezza, e io ne sono testimonio. Nulla è più stupefacente della magnificenza del suo palazzo. Quando questo principe vuol comparire in pubblico si erige un trono su un elefante su cui egli siede e incede in mezzo a due file di ministri, di favoriti e di altre genti della sua corte. Innanzi a lui, sullo stesso elefante, sta un ufficiale con in mano una lancia d’oro e dietro al trono sta ritto un altro ufficiale che porta una colonna d’oro, in cima alla quale c’è uno smeraldo lungo circa mezzo piede e dello spessore di un pollice. Egli è preceduto da una guardia di mille uomini vestiti di drappi d’oro e di seta, montati sopra elefanti riccamente coperti. Mentre il re è in marcia, l’ufficiale, che è davanti a lui sullo stesso elefante, grida di tanto in tanto ad alta voce: “Ecco il gran monarca, il potente e formidabile sultano delle Indie, il cui palazzo è coperto di centomila rubini, e che possiede ventimila corone di diamanti! Ecco il monarca coronato, il più grande di quanti furono!”. Dopo queste parole, l’ufficiale che è dietro al trono grida a sua volta: “Questo monarca grande e possente, deve morire, deve morire, deve morire!”. L’ufficiale davanti ripiglia e grida in seguito: “Lode a colui che vive e che non muore!”. Inoltre, il re di Serendib è così giusto, che non ci sono giudici nella sua capitale, né nel resto dei suoi stati: i suoi popoli non ne hanno bisogno; essi conoscono e osservano da se stessi la giustizia: e non si discostano mai dal loro dovere. Così i tribunali e i magistrati sono inutili”.
Il califfo rimase contentissimo del mio discorso.
“La saggezza di questo re”, disse, “si mostra nella sua lettera: e dopo quanto mi avete detto bisogna confessare che la sua saggezza è degna dei suoi popoli, e i suoi popoli degni di essa.” Dopo queste parole egli mi licenziò e mi rimandò con un ricco dono.”
Sindibàd a questo punto finì di parlare e fece dare cento dinar a Hindbàd. Ritornarono tutti il giorno seguente, e Sindibàd raccontò il suo settimo ed ultimo viaggio in questi termini.
- Fiaberella

