Storia di Sinbad il marinaio-Parte VII
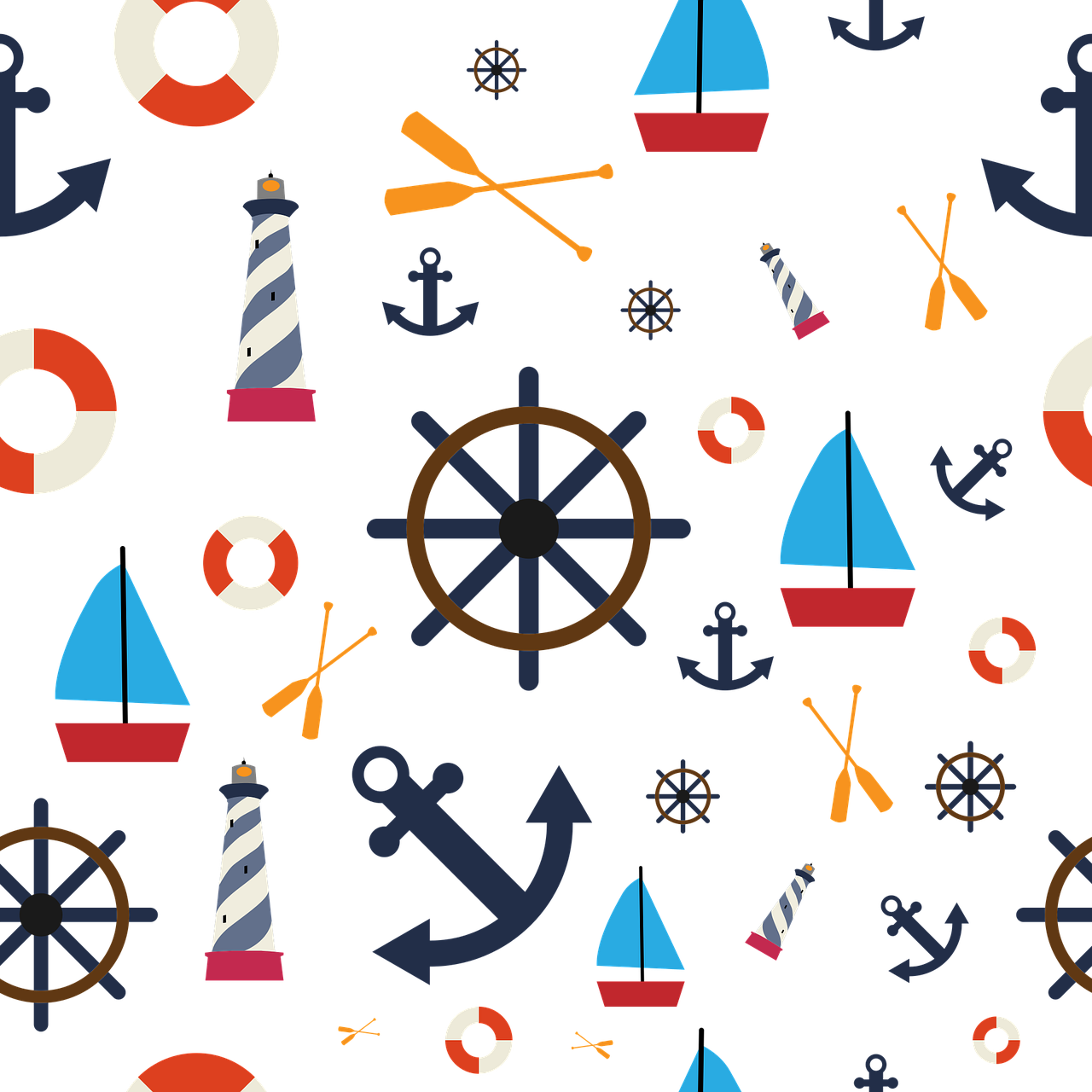
Al ritorno dal mio sesto viaggio abbandonai assolutamente l’idea di farne altri; ero ormai in una età che esigeva riposo, e inoltre avevo promesso a me stesso di non espormi più ai pericoli. Perciò pensavo solo a passare dolcemente il resto della vita. Un giorno, in cui davo un banchetto a un gruppo di amici, vennero ad avvertirmi che un ufficiale del califfo chiedeva di me. Mi alzai da tavola e gli andai incontro. “Il califfo”, mi disse, “mi ha incaricato di venirvi a dire che vuole parlarvi.” Seguii al palazzo l’ufficiale; e il principe, che salutai prosternandomi ai suoi piedi: “Sindibàd”, mi disse, “ho bisogno di voi; occorre che andiate a portare la mia risposta e i miei doni al re di Serendib. E ben giusto che io contraccambi la gentilezza ricevuta”. Il comando del califfo fu per me un fulmine a ciel sereno. “Sono pronto”, gli dissi, “a eseguire tutto ciò che mi ordinerà la vostra maestà! Ma vi supplico umilmente di pensare che sono indebolito dagli incredibili travagli sofferti ed ho fatto voto di non uscire più da Bagdad.” Presi da ciò occasione per narrargli minutamente tutte le mie avventure ed egli ebbe la pazienza di ascoltarmi fino alla fine. Appena ebbi cessato di parlare, disse: “Confesso che questi avvenimenti sono straordinari: ma non bisogna che vi impediscano di fare per amor mio il viaggio propostovi, trattandosi solo di andare all’isola di Serendib per eseguire la commissione che vi darò. Dopo ciò sarete libero di ritornare qui; ma bisogna andarci, poiché non sarebbe consono al mio decoro e alla mia dignità di rimanere obbligato al re di quell’isola”. Siccome vidi che il califfo esigeva ciò in modo assoluto, gli dissi che ero pronto a obbedirgli. Ne ebbe molta gioia, e mi fece dare mille dinar per le spese di viaggio.
In pochi giorni mi preparai alla partenza, e appena ricevuto i doni del califfo con la lettera di sua propria mano, partii e presi il cammino di Bassora, dove m’imbarcai. La navigazione fu ottima e giunsi all’isola di Serendib. Là giunto esposi ai ministri la commissione di cui ero incaricato e li pregai di farmi dare udienza senza indugio: il che fecero. Fui così condotto con tutti gli onori al palazzo e salutai il re, prosternandomi secondo l’uso. Il principe mi riconobbe al primo sguardo e dimostrò grande gioia nel rivedermi. “Ah! Sindibàd”, mi disse, “siate il benvenuto! Vi giuro di avere pensato spessissimo a voi dopo la vostra partenza. Benedico questo giorno, in cui ci vediamo di nuovo.” Gli feci i miei complimenti e, dopo averlo ringraziato della sua bontà, gli presentai la lettera ed il dono del califfo, che egli ricevette con tutti i segni di una grande soddisfazione. Il califfo gli inviava un letto completo di drappo d’oro, valutato mille dinar; cinquanta vesti di una stoffa ricchissima, ed altre cento della più fine tela bianca del Cairo, di Suez, di Cuba e di Alessandria; un altro letto cremisino e un altro di un’altra maniera; un vaso d’agata più largo che profondo, dello spessore di un dito e della larghezza di un piede, il cui fondo rappresentava in bassorilievo un uomo con un ginocchio a terra, armato di un arco e di una freccia, sul punto di tirare contro un leone; gli mandava infine una ricca tavola, che si credeva per tradizione provenire dal gran Salomone. La lettera era concepita in questi termini:
«Salute in nome della suprema guida del retto cammino, al possente e felice sultano da parte di Abd Allah Harùn ar-Rashìd, che Iddio ha posto nel posto d’onore, dopo i suoi antenati di felice memoria. Noi abbiamo ricevuto con gioia la vostra lettera e vi mandiamo questa, emanata dal consiglio della nostra Porta, giardino delle menti elevate. Noi speriamo che nel gettarvi gli occhi sopra, conoscerete la nostra buona intenzione, e la gradirete. Addio».
Il re di Serendib ebbe un gran piacere, vedendo che il califfo aveva corrisposto alla sua amicizia. Poco tempo dopo questa udienza io feci in modo di averne un’altra per chiedere commiato. Ebbi qualche difficoltà ad ottenere il permesso di partire ma l’ottenni alla fine e il re, nel congedarmi, mi fece un dono molto considerevole. Mi imbarcai subito con l’intenzione di ritornare a Bagdad, ma non ebbi la fortuna di giungervi come speravo. Dio dispose altrimenti. Tre o quattro giorni dopo la mia partenza, fummo assaliti dai corsari, che s’impadronirono della nostra nave, perché non eravamo, in nessun modo, in condizione di difenderci. Alcune persone dell’equipaggio vollero fare resistenza, ma persero la vita; io e tutti quelli che ebbero la prudenza di non opporsi al disegno dei corsari, fummo fatti schiavi. Dopo che i corsari ci ebbero spogliati e rivestiti di abiti logori in luogo dei nostri, ci condussero in una grande isola molto lontana, dove ci vendettero. Io caddi tra le mani di un ricco mercante, il quale, appena m’ebbe comprato, mi condusse a casa sua, dove mi fece mangiare, bere e vestire da schiavo. Alcuni giorni dopo, dato che non si era ancora informato su chi fossi, mi domandò se conoscevo qualche mestiere. Gli risposi, senza farmi conoscere meglio, che non ero un artigiano, ma un mercante e che i corsari che mi avevano venduto mi avevano tolto tutto quello che possedevo. “Ma ditemi”, egli riprese, “non potreste tirare con l’arco?” Gli dissi che lo avevo fatto, nella mia giovinezza, e che non l’avevo dimenticato. Allora mi diede un arco e delle frecce, e avendomi fatto salire dietro di lui su un elefante, mi condusse in una foresta, lontana dalla città qualche ora di cammino, e la cui estensione era enorme. Ci inoltrammo molto e, quando giudicò opportuno fermarsi, mi fece scendere. Poi, mostrandomi un grande albero, mi disse: “Salite su quell’albero, e tirate agli elefanti che vedrete passare, e che sono numerosissimi in questa foresta. Se ne cade qualcuno venite ad avvertirmene”. Dopo avermi detto questo, mi lasciò dei viveri e riprese il cammino della città. Io restai sull’albero alla posta per tutta la notte. Non scorsi nessun elefante; ma all’indomani, appena sorse il sole, ne vidi comparire un gran numero. Scagliai parecchie frecce, e infine un elefante cadde a terra. Gli altri si ritirarono e mi lasciarono la libertà di andare ad avvisare il mio padrone della caccia che avevo fatta. In ricompensa di questa notizia mi regalò un buon pranzo, lodò la mia destrezza e mi fece molti complimenti. Quindi andammo insieme nella foresta a scavare una fossa, in cui sotterrammo l’elefante ucciso. Il mio padrone si proponeva di ritornare quando l’animale fosse imputridito per portar via le zanne e venderle. Continuai per due mesi quella caccia, e non passava giorno in cui non uccidessi un elefante. Non mi mettevo sempre alla posta sul medesimo albero, ma ora sull’uno ora sull’altro.
Un mattino, mentre aspettavo l’arrivo degli elefanti, mi accorsi con estremo stupore che invece di passare davanti a me, attraversando la foresta come al solito, si dirigevano verso di me con orribile fracasso e in sì gran numero che la terra ne era coperta e tremava sotto i loro passi. Si avvicinarono all’albero su cui mi ero arrampicato, e lo accerchiarono, con le proboscidi tese e gli occhi fissi su di me. A quello spettacolo sorprendente rimasi immobile, preso da tale spavento, che l’arco e le frecce mi caddero dalle mani. E non ero agitato da vano timore: perché dopo qualche momento un elefante più grosso circondò la parte inferiore dell’albero con la proboscide, e, con uno sforzo possente, riuscì a sradicarlo e a rovesciarlo a terra. Caddi insieme all’albero, ma l’elefante mi afferrò con la proboscide, mi caricò sul dorso, dove mi sedetti più morto che vivo col turcasso appeso alla spalla. Esso si pose quindi alla testa di tutti gli altri che lo seguivano in branco, e mi portò fino ad un luogo, dove, avendomi posto a terra, si ritirò con tutti quelli che l’accompagnavano. Immaginate lo stato in cui ero: credevo di sognare. Finalmente, dopo essere stato qualche tempo steso in quel luogo, non vedendo più alcun elefante, mi alzai e guardai intorno: ero su di una collina tutta coperta d’ossa e di denti di elefante. Vi confesso che quella vista mi fece fare una infinità di riflessioni. Ammirai l’istinto di quegli animali e fui convinto che quello era il loro cimitero, e che mi avevano condotto là a bella posta per mostrarmelo affinché cessassi di perseguitarli, poiché io lo facevo solo per avere le loro zanne. Non mi fermai sulla collina; volsi i passi verso la città e, dopo aver camminato un giorno e una notte, giunsi a casa del mio padrone.
Non incontrai nessun elefante lungo il cammino, e ne dedussi che si fossero allontanati più addentro nella foresta per lasciarmi in perfetta libertà. Appena il mio padrone m’ebbe scorto, mi disse: “Ah! povero Sindibàd, ero in grande ansietà perché non sapevo che ne era stato di te! Sono andato nella foresta, ho trovato un albero sradicato, un arco e delle frecce per terra, e, dopo-averti inutilmente cercato, disperavo di rivederti. Raccontami, te ne prego, ciò che t’è capitato, e per quale ventura sei ancora in vita”. Soddisfeci la sua curiosità, e il giorno appresso, essendo andati tutti e due sulla collina, constatò con estrema gioia che gli avevo detto la verità. Caricammo l’elefante, sul quale eravamo venuti, di quante zanne poteva portare, e quando fummo di ritorno: “Fratello”, mi disse, “poiché non voglio più trattarti da schiavo, dopo che hai fatto una scoperta che dovrà arricchirmi. Dio ti colmi d’ogni sorta di bene e di prosperità. Io dichiaro davanti a lui, che ti rendo libero fin da questo istante. Gli elefanti della nostra foresta causano la morte ogni anno di un’infinità di schiavi, mandati da noi a cercare avorio. Per quanti consigli possiamo dare loro, essi perdono presto o tardi la vita, vittime dell’astuzia di questi animali. Iddio ti ha liberato dalla loro furia, e questo è un segno che ti ama, che il mondo ha bisogno di te perché devi fare del bene. Tu mi hai procurato un incredibile vantaggio: finora non abbiamo potuto avere l’avorio se non esponendo la vita dei nostri schiavi; e ora ecco tutta la nostra città arricchita per mezzo tuo. Non credere che io pretenda di averti ricompensato donandoti la libertà; voglio aggiungere a questo dono dei beni considerevoli. Potrei invitare tutta la città a contribuire alla tua fortuna: ma è questo un onore che voglio avere io solo”.
A questo discorso risposi: “Padrone, Dio vi conservi! La libertà accordatami basta largamente per sdebitarvi verso di me: e per unica ricompensa del servizio che ho avuto la fortuna di rendere a voi e alla vostra città, vi domando il permesso di ritornare al mio paese”. “Ebbene”, replicò, “il monsone porterà qui ben presto delle navi che verranno a caricare avorio. Io allora ti lascerò partire.” Lo ringraziai di nuovo della libertà datami, come pure delle buone intenzioni che aveva per me. Restai in casa sua attendendo il monsone, e durante quel tempo facemmo tanti viaggi alla collina da riempire i suoi magazzini d’avorio. Tutti i mercanti della città fecero lo stesso, poiché la cosa non restò nascosta. Le navi alla fine arrivarono, e il mio padrone, avendo egli stesso scelto quella sulla quale dovevo imbarcarmi, la caricò d’avorio per conto mio. Non si dimenticò di farvi mettere delle provviste in abbondanza per il viaggio, e inoltre m’obbligò ad accettare dei regali di gran prezzo, fra le rarità del paese. Dopo averlo ringraziato quanto mi fu possibile di tutti i benefici che avevo ricevuti da lui, m’imbarcai. Partimmo, e siccome l’avventura che m’aveva procurato la libertà era davvero straordinaria, io ne avevo la mente incessantemente occupata. Ci fermammo in alcune isole per riposare. La nostra nave, partita da un porto delle Indie, vi stava tornando. Trassi dalla vendita del mio avorio una grossa somma di denaro, comprai parecchie cose rare per farne dei regali, indi mi unii a una grossa carovana di mercanti e giunsi felicemente a Bagdad. Andai prima d’ogni altra cosa a render conto al califfo della mia ambasciata. Egli mi disse che era stato molto inquieto per la durata del mio viaggio. Quando gli raccontai l’avventura degli elefanti, ne parve molto meravigliato e avrebbe rifiutato di prestarvi fede, se la mia sincerità non gli fosse stata nota. Trovò questa storia e le altre così curiose che incaricò uno dei suoi segretari di scriverle in caratteri d’oro, per essere conservate nel suo archivio. Mi ritirai contentissimo dell’onore e dei doni che avevo ricevuti, e poi mi dedicai interamente ai miei parenti e agli amici.
Così Sindibàd terminò il racconto del suo settimo e ultimo viaggio, e volgendosi quindi a Hindbàd: “Ebbene, amico mio”, soggiunse, “avete mai udito che qualcuno abbia sofferto al pari di me? Non è forse giusto, che dopo tanti travagli, io goda d’una vita piacevole e tranquilla?”. Appena proferite queste parole, Hindbàd gli si accostò e baciandogli la mano, disse: “Signore, avete sopportati orribili pericoli, e le mie pene non sono paragonabili alle vostre: se esse mi affliggono, me ne consolo col piccolo profitto che traggo. Voi meritate non solo una vita tranquilla, ma siete degno anche di tutti i beni immaginabili, poiché ne fate buon uso e siete tanto generoso. Continuate adunque a vivere nella gioia fino all’ora della vostra morte”. Sindibàd gli fece dare altri cento dinar, lo trattò come un amico, gli disse di abbandonare il mestiere di facchino e di continuare a venire a mangiare tutti i giorni da lui.
- Fiaberella

